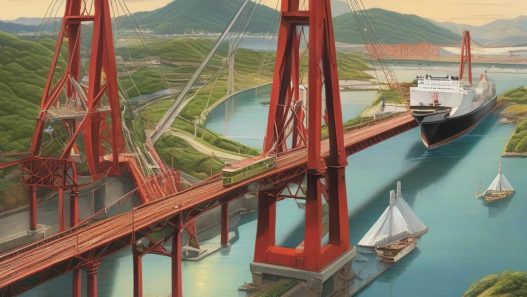Il discorso dei rapporti tra l’Europa e gli Stati Uniti è un discorso complesso e soprattutto sbagliato nella premessa. Perché ci possano essere rapporti diretti tra Stati Uniti ed Europa dovrebbe esistere un’Europa. O meglio, dovrebbe esistere un’Europa politicamente coesa, in grado di prendere delle decisioni, non dico su un piano paritetico, ma quantomeno abbastanza similare a quello dei cugini d’oltreoceano. Questo non si verifica assolutamente perché le costruzioni dei due sistemi sono profondamente diverse.
L’Europa è un’unione fortemente imperfetta. Ha un assetto più simile a una confederazione, ma continua a non avere organismi efficaci per trovare posizioni di sintesi sulle situazioni più importanti. Gli Stati Uniti, invece, sono un’unione sin da Abramo Lincoln, che riuscì a perfezionare il potere del governo centrale su tematiche essenziali. Gli americani hanno un presidente, un parlamento, una corte suprema che garantisce i diritti dello Stato dell’Unione, che in materia di difesa, di sicurezza, di politica estera e per altre importanti funzioni è superiore ai singoli stati.
L’Europa continua a rimandare le decisioni fondamentali ai singoli stati. Quindi ci sono due Stati fondamentali da analizzare se si analizza l’Europa, perché sono l’asse portante dell’odierna Europa. Questi stati sono la Francia e la Germania, due paesi profondamente in crisi per la situazione interna al loro sistema politico. In Francia questa crisi è diventata palese, causa le recenti elezioni; in Germania è presunta, visto quanto recentemente accaduto in Turingia. Gli altri paesi (Italia, Belgio, Olanda, Spagna, Grecia) sono collaterali all’asse portante che è sostanzialmente franco-tedesco. Poi vi si aggregano paesi francofoni e paesi vicini storicamente alla Germania, ma si aggregano come satelliti di un’egemonia più forte.
Il motore economico, produttivo e commerciale è sicuramente quello tedesco. Mentre, con la fuoriuscita dell’Inghilterra, il sistema militare più importante, per quanto ben lontano dalla dimensione dell’alleato statunitense, è quello francese. La Francia è riuscita anche a mantenere una politica estera interessante, molto più indipendente di tanti altri paesi europei.
Lo spartiacque del secondo conflitto mondiale ancora oggi ha un peso di non trascurabile rilievo. I paesi sconfitti, Italia e Germania, persero di fatto la loro sovranità, o meglio si trovarono a una sovranità limitata. Mentre un paese come la Francia, che non aveva certo militarmente vinto la guerra, ma era riuscito, grazie all’abilità del generale Charles de Gaulle, a trasmettere l’idea di far parte del novero delle potenze vincitrici, ha mantenuto un’indipendenza molto superiore.
La Francia deve essere analizzata in maniera separata, alla luce del concetto di grandeur, che è alla base della politica estera francese da secoli. La Francia si vede ancora come una grande potenza mondiale. Altro grandissimo freno all’Europa: in un certo senso si vuole ancora un impero francese, capace di esercitare la propria influenza sulla non trascurabile parte del mondo francofono. Un impero ovviamente limitato rispetto alla grande sfera dell’English-speaking world, ma comunque, nel frastagliato panorama dei piccoli stati europei, un impero più che forte e influente.
L’uscita della Gran Bretagna dall’Europa ha determinato una diversificazione assoluta dei rapporti. L’Europa non esiste come potenza, ma c’è chi guida questa sgangherata unione e chi è guidato. La Francia in questa sgangherata unione cerca di stabilire il ruolo di paese egemone per far pesare ancora di più la propria influenza sugli altri e accreditarsi agli occhi delle potenze internazionali. È estremamente vulnerabile da questo punto di vista all’egemonia tedesca.
Innanzitutto perché la Germania dovrebbe avere delle forze armate adeguate a una grande potenza industriale, ma una simile politica non è più portata avanti dai tedeschi dal dopoguerra; inoltre presenta il grave difetto di indispettire fortemente l’alleato francese, che ha sempre visto nel riarmo della Germania qualcosa di insidioso. Ci sono ovviamente profonde ragioni storiche. Ma, anche scongiurando una guerra franco-tedesca che oggi potrebbe essere vista come anacronistica, c’è una ragione di fondo in merito al peso sullo scacchiere internazionale.
La Francia dispone del più grande esercito europeo e, se questo venisse conteso dai tedeschi, l’influenza internazionale nelle relazioni francesi ne verrebbe fortemente limitata. Dal canto suo, la Germania ha tutto l’interesse a riappacificare con l’Est. Guardiamo innanzitutto un fattore sostanziale essenziale: le relazioni bilaterali tra Russia e Germania. Prima dei conflitti mondiali tali relazioni furono sempre travagliate, ma con punte di forte cooperazione. Si può anche dire che c’è un diretto legame tra le dinastie tedesche e la dinastia imperiale russa. Non fu così assurdo il trattato di non aggressione tra Molotov e Ribbentrop, legato al comune interesse di una grande pacificazione che consentisse alla Germania di contenere la Francia e l’Inghilterra prendendo largo piede in Europa occidentale, e alla Russia (al tempo Unione Sovietica) una tranquillità forte a Occidente per concentrarsi verso l’Est.
Attualmente, la Germania si trova attanagliata in una difficile situazione interna, esattamente come la Francia. Aggravata dal fatto che, se la Francia, grande potenza coloniale, ha generato degli anticorpi capaci di gestire il grave problema della società multiculturale, la Germania si trova di fronte a una situazione molto più complessa perché la sua storia coloniale fu breve, travagliata e soprattutto localizzata. Inoltre, l’Europa, proprio per l’assenza di una guida politica efficace, è condizionata per forza di cose dall’esito delle elezioni americane e dall’atteggiamento che il presidente degli Stati Uniti ha verso di essa. L’Europa non può fare a meno dell’America, come l’America non può fare a meno di avere influenza in Europa.
Per questo le elezioni americane saranno uno spartiacque importante. Kamala Harris e Donald Trump sanno ambedue di dover mantenere un’influenza in Europa. Ma mentre la prima non riesce a concentrare sforzi efficaci in punti strategici, continuando a puntare a un’egemonia mondiale troppo fragile e non basata su una realpolitik che guardi a presidiare i punti indispensabili, il secondo dovrà stabilire rapporti di special relationship con tre paesi fondamentali.
Il primo è l’Inghilterra, perché qualunque presidente americano ha sempre portato avanti una politica di lavoro comune con gli inglesi: l’Inghilterra ha una sensibilità affine a quella americana ed è il paese a minor vocazione europeista. Poi con Italia e Germania, che sono i paesi perdenti del secondo conflitto mondiale, quindi il peso statunitense è ancora più forte sia per gli aiuti offerti nel dopoguerra che per le relazioni di forza stabilite anche con i trattati militari. L’Italia offre la chiave di volta per il controllo del Mediterraneo e l’inserimento nella Mittel Europa, mentre la Germania offre il cuore dell’Europa.
Dunque, rispetto ad alleanze militari più costose ed estese, una concentrazione strategica verso questi tre paesi consentirebbe agli Stati Uniti di aprire relazioni più forti, di dover sostenere sempre questi tre ma di avere molta più mano libera per un impegno delle proprie forze sul fronte Pacifico, che, visto l’ingrandimento cinese, diventa il fronte essenziale. Questo darebbe un ruolo di secondo piano alla Francia, che non sarebbe più il primo esercito europeo ma dovrebbe accodarsi, eventualmente finanziando per se stessa, per rimanere al tavolo dei grandi.
Un quadro del genere lascia presagire che l’Europa possa avere, se non una guida differente, una ridistribuzione degli equilibri di potere.