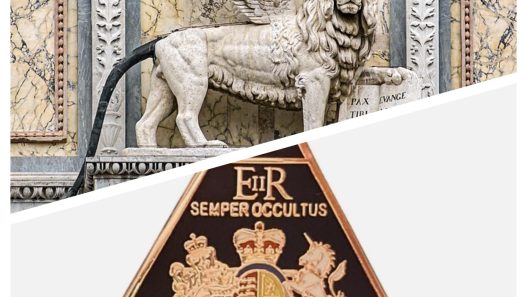Da sempre mi sono chiesto quali fossero i valori ed i principi del mondo romano, un mondo tanto vicino ed attuale quanto lontano dal nostro. Nella nostra vita quotidiana compiamo gesti, abbiamo rapporti interpersonali, stringiamo accordi e mettiamo in essere rapporti giuridici. Raramente ci accorgiamo che tali azioni sono guidate da valori e principi che abbiamo fatto nostri e che nel tempo si sono trasformati.
Ogni epoca storica è fondata su valori e principi diversi, fulcro della società.
Roma ha da sempre basato la sua forza su valori incentrati sulla religiosità e su una visione etica della società e della persona, in particolare la Roma dei primordi. Il civis romanus è emblematico in tal senso.
Quando parliamo di religiosità e/o di religione, dobbiamo chiarire cosa significa e cosa intendono i romani con il termine “religio”. Generalmente, con tale termine, si fa riferimento ad un patto stipulato tra uomo e divinità (la pax deorum è significativa in tal senso), quindi ne si osservano tutte le norme che disciplinano il rapporto tra sacro e profano. Tutto ciò che riguarda il diritto, la società, la famiglia si basa su ciò che è sacro e così anche l’etica, legata indissolubilmente e fondata sulla religio. Il civis romanus si caratterizza infatti per le sue qualità etiche, fondandosi tutte sul concetto di pietas. I Romani, difatti, intendono la società come il normale convivere di uomini e dei. Il culto degli dei è proprio il legame che la città ha con essi.
Con il termine pietas, facciamo riferimento alla percezione che si ha del dovere e distinguiamo diversi campi di applicazione e di manifestazione. Così si ha pietas nella società attraverso la famiglia, nel rapporto tra padre e figli e per estensione si ha pietas verso la patria. Sempre in ambito familiare essa si manifesta verso il culto degli antenati, i Lari ed i Penati.
La famiglia, nel periodo qui preso ad esame, viene gestita dal pater familias avendo il totale potere e dominio nei confronti della moglie e dei propri figli ed esercitando su di essi la patria potestà. Il figlio, arrivato alla maggiore età, può fondare una sua famiglia, ma tutto ciò che entra nella sua sfera giuridica appartiene legalmente al padre. Infatti, a differenza del mondo greco, dove il maggiorenne è libero dalla potestà paterna, nel mondo romano l’autorità del pater familias non cessa alla maggiore età del figlio né per sua volontà, ma alla morte di questi. In caso di adozione, invece, la patria potestà spetta al padre adottivo, trasmettendosi tale diritto dall’uno all’altro. Per le figlie il diritto si trasferisce dal padre al marito, entrando di conseguenza nella sua sfera soggettiva. Al contrario di quanto si possa pensare, i figli e la moglie sono persone e non cose, infatti i loro diritti sono soltanto “sospesi”, perfezionandosi alla morte del pater familias. Così non avviene, ad esempio, per lo schiavo in quanto la sua posizione giuridica resta la stessa.
In campo militare, invece, si esprime la pietas con il combattimento. Il soldato accetta di sacrificare la propria vita in difesa del suo popolo e della sua patria. I Romani fanno della virtù la base fondante della vita collettiva, requisito necessario in caso si voglia intraprendere qualsiasi tipo di carriera pubblica.

Due episodi qui di seguito vi illustro, raccontati da Tito Livio, esemplificativi del mondo romano qui esaminato. Il primo si riferisce al console Tito Manlio Torquato durante le guerre contro i Latini nel 340 a. C. Il console ha un figlio, Tito Manlio, che sfida a duello e vince il cavaliere nemico Gemino Mecio disobbedendo all’ordine del padre console di mantenere la propria posizione e di non dare battaglia. Il padre convoca l’esercito, dichiara che il proprio figlio ha violato la disciplina militare mancando di rispetto all’autorità del console abbandonando il suo posto. Dopodiché condanna a morte Tito Manlio davanti lo stupore di tutto l’esercito. Tito Manlio Torquato è costretto a scegliere tra lo Stato e l’affetto che un padre ha verso il proprio figlio. Cito, a riguardo, il passo di Tito Livio: “Poiché tu, Tito Manlio, senza portare rispetto né all’autorità consolare né alla patria potestà, hai abbandonato il tuo posto, contro i nostri ordini, per affrontare il nemico, e con la tua personale iniziativa hai violato quella disciplina militare grazie alla quale la potenza romana è rimasta tale fino al giorno d’oggi, mi hai costretto a scegliere se dimenticare lo Stato o me stesso, se dobbiamo noi essere puniti per la nostra colpa o piuttosto è il paese a dover pagare per le nostre colpe un prezzo tanto alto. Stabiliremo un precedente penoso, che però sarà d’aiuto per i giovani di domani. Quanto a me, sono toccato non solo dall’affetto naturale che un padre ha verso i figli, ma anche dalla dimostrazione di valore che ti ha fuorviato con una falsa parvenza di gloria. Ma visto che l’autorità consolare dev’essere o consolidata dalla tua morte oppure del tutto abrogata dalla tua impunità, e siccome penso che nemmeno tu, se in te c’è una goccia del mio sangue, rifiuteresti di ristabilire la disciplina militare messa in crisi dalla tua colpa, va, o littore, e legalo al palo[1]”.
L’altro episodio, a cui faccio riferimento, vede coinvolto Caio Muzio Scevola. A seguito della cacciata del re Tarquinio Il Superbo, Porsenna, re etrusco, assedia Roma. Muzio Scevola, stanco della situazione e ridotta Roma alla fame, si rivolge al Senato per avere la facoltà di andare nel campo nemico ed uccidere il re etrusco. Ottenuto il consenso, nasconde un pugnale sotto le vesti e si dirige verso l’accampamento nemico. Qui, non sapendo di preciso chi fosse il re, uccide il suo scriba. Catturato, posa la mano destra in un braciere accesso, rea di aver ucciso la persona sbagliata. Porsenna, stupito dall’eroico gesto, decide di liberare Muzio Scevola, il quale dichiara: “Sono cittadino romano, mi chiamo Gaio Mucio. Nemico ho voluto uccidere un nemico, e avrò non minor coraggio a morire di quanto ne ho avuto a uccidere: è virtù romana agire e sopportare da forti. E non io solo ho tale animo verso di te: dietro di me vi è una lunga schiera di uomini che ambiscono allo stesso onore. Preparati dunque a questo cimento, se così ti piace, a combattere ad ogni momento per la salvezza della tua vita, e a tenere nel vestibolo della reggia un ferro nemico: questa è la guerra che ti dichiara la gioventù romana. Non un esercito, non una battaglia hai da temere: la lotta sarà contro te solo da parte di singoli uomini […].Per ringraziarti della tua clemenza, voglio rivelarti che trecento giovani nobili romani hanno solennemente giurato di ucciderti. Il fato ha stabilito che io fossi il primo, e ora sono qui davanti a te perché ho fallito. Ma prima o poi qualcuno degli altri duecentonovantanove riuscirà nell’intento[2]”.

Nel diritto, viceversa, la pietas si esprime per mezzo della iustitia ed è emblematico in tal senso la definizione che Ulpiano dà proprio a tale termine, intesa come “costante e perpetua volontà di attribuire a ciascuno il suo diritto[3]”. Nel mondo romano pietas e iustitia sono indissolubili in quanto Roma basa il suo diritto sulla legge divina. Così, allo stesso modo, diventa giusto tutto ciò che è conforme al diritto. In Cicerone, infatti, il requisito imprescindibile della giustizia è la fides a testimonianza di quanto pattuito. Generalmente i romani esprimevano la fides tramite una stretta di mano destra, atto a suggellare quanto concordato.
La parola ius viene pronunciata per la prima volta all’interno del collegio dei pontefici. Esso si fonda sul ricordo dei mores, esprimendosi come un modo di risposta dei pontefici ai quesiti posti dai patres familias su ciò che è ius, cioè il comportamento da osservare affinché le azioni siano conformi al rispetto delle relazioni con gli altri. Il rapporto tra ius e divino viene ad incrinarsi quando la società inizia ad avere una visione politica dei suoi rapporti ed emblematico in tal senso è la creazione delle XII tavole. Infatti più la politica comincia ad avere un peso nella società più la religione inizia a perdere terreno, contribuendo inevitabilmente ad un diffondersi del ius in chiave civile.
In questa veloce analisi sui valori e principi fondanti del mondo romano possiamo capire quanto esso sia così distante dal nostro, ma allo stesso tempo così vicino. Oggi sarebbe impensabile poter vivere e regolare i nostri rapporti fondando e rapportando interamente i nostri valori su quelli del mondo romano, ma sicuramente ci sono valori che appartengono all’umanità in quanto tale e che non dovrebbero mai essere dimenticati.
Mi riferisco, ad esempio, al valore della giustizia, fondamento del vivere civile. Studiando società e popoli lontani da noi possiamo comprendere quanto i valori possano influenzare la quotidianità e regolare rapporti privati e pubblici.
Non con un approccio critico, bensì costruttivo ed umile, possiamo comprendere e relazionarci con culture diverse e lontane dalla nostra. Così come, per ogni buon storico, bisogna studiare la storia osservandola con gli occhi del passato e non con quelli del presente.
- Tito Livio, Ab Urbe condita, VIII, 7 ↑
- Tito Livio, Ab Urbe condita, II, 12 ↑
- Ulpiano, Regole, 1.1.10pr ↑